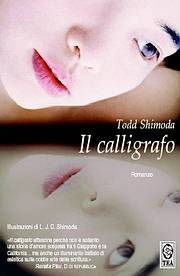 Appena ho letto il titolo e visto la copertina, ho pensato: ecco, questo è un libro da spiaggia. Non nel senso sprezzante della parola, ma intendendo una lettura piacevole e non particolarmente impegnativa. E poi il formato tascabile trova sempre posto nello zaino da trekking o nella borsa da spiaggia.
Appena ho letto il titolo e visto la copertina, ho pensato: ecco, questo è un libro da spiaggia. Non nel senso sprezzante della parola, ma intendendo una lettura piacevole e non particolarmente impegnativa. E poi il formato tascabile trova sempre posto nello zaino da trekking o nella borsa da spiaggia.
Il volume in questione (così svelo l’arcano) è Il calligrafo (ed. Tea [ma potreste trovarlo anche nella vecchia edizione Longanesi], pp. 376, € 8,50; illustrato) di Todd Shimoda, nippoamericano di terza generazione e ricercatore nell’ambito dell’intelligenza artificiale.
The Fourth Treasure (Il quarto tesoro) – questo il titolo originale – si sviluppa in tre diverse epoche e due città: da un lato, abbiamo la Berkeley contemporanea, in cui vive una studentessa di neuroscienze appassionata di shodô (il sentiero artistico-spirituale della calligrafia); dall’altro, troviamo la Kyoto degli anni Settanta e quella della metà del XVII sec., teatro d’amori e lotte che ruotano attorno al mondo dello shodô.
A voi uno stralcio del libro:
I N T E R L U D I O
Foglie cremisi/ che cadonoNOVEMBRE 1975, KYOTO, GIAPPONE
KIICHI SHIMANO, il sensei capo della Scuola di calligrafia Daizen, gettò uno sguardo fuori del suo studio, nel giardino. La brezza autunnale aveva strappato dall’acero le foglie cremisi e le aveva sparpagliate sul terreno ricoperto di muschio, creando un motivo che era casuale, e tuttavia possedeva un forte equilibrio e un ritmo vivace. Così facile per la natura, così difficile per l’artista. La differenza deve risiedere nel fatto che l’artista crea con il pensiero e i sentimenti. La natura crea la sua arte senza nessuna delle due cose e obbedisce solo a poche semplici regole – la gravità, la forza del vento, il cambiamento delle stagioni – in infinite combinazioni.
Il sensei Daizen prese il pennello da calligrafo mentre si concentrava sul kanji per «cremisi». La parola era parte di una poesia che aveva appena iniziato:
Foglie cremisi
che cadono…Doveva riconoscere che non era un granché come poesia.
Non aveva tempo per scrivere poesie migliori, non da quando era stato nominato ventinovesimo sensei capo della scuola Daizen, qualche mese prima. Programmare le lezioni, assegnare gli studenti agli insegnanti della scuola, giudicare le gare, occuparsi delle finanze: questi erano alcuni dei molti doveri che aveva ereditato quale sensei Daizen. E c’erano le interviste, l’ultima aveva avuto luogo proprio quella mattina, per un programma mattutino in diretta da una stazione televisiva di Osaka. L’intervistatrice, sebbene entusiasta (fin troppo a tratti) sembrava interessata solo agli aspetti superficiali dello shodo: “Che tipo di pennello usa? Dove si procura l’inchiostro? Con che frequenza si esercita? Per “quanto tempo?” Esaurito il suo repertorio, gli aveva chiesto l’età e, quando lui aveva risposto, lo aveva battezzato “Giovane Sensei”, aveva trentaquattro anni – quindici o venti in meno del solito per un nuovo sensei capo – ed era il secondo più giovane sensei Daizen. Il più giovane era stato il samurai Sakata, il quindicesimo sensei capo, conosciuto come il padre dell’era attuale, quella della callìgrafia giapponese competitiva.
L’ultima domanda della giornalista era stata: come pensa di comportarsi il Giovane Sensei nel prossimo Concorso Daizen-Kurokawa?
La giornillista si riferiya alla gara tra la sua scuola e la Scuola di calligrafia Kurokawa. Il sensei Daizen aveva previsto la domanda e aveva preparato una breve storia del concorso nel caso che la giornalisia gliel’avesse chiesto: nel 1659, Sakata e il fondatore della scuola Kurokawa diedero inizio al Concorso di calligrafia Daizen~Kurokawa, tutttora il più pretigioso del Giappone. Tenutosi da allora ogni tre anni, serviva ad assicurare che le due scuole mantenessero il loro primato.
Il sensei Daizen aveva risposto che non sapeva che risultato avrebbe ottenuto, ma si sarebbe impegnato a fondo per fare del suo meglio.
Sperava che l’intervistatrice gli chiedesse perché la calligrafia, se praticata in modo corretto, è intrisa di potere spirituale. Voleva che gli chiedessè perché è necessario dedicare alla calligrafia tanto esercizio persino per raggiungere risultati mediocri.
 Per tutti i fan di Murakami, in attesa che la sua ultima fatica letteraria, 1Q84, esca in Italia, un’anticipazione del terzo volume, appena apparso in Giappone. Dei due precedenti abbiamo già parlato
Per tutti i fan di Murakami, in attesa che la sua ultima fatica letteraria, 1Q84, esca in Italia, un’anticipazione del terzo volume, appena apparso in Giappone. Dei due precedenti abbiamo già parlato  novità: a marzo è infatti uscito in libreria, presso i raffinati tipi dell’Adelphi, Ricordi di mia madre di Inoue Yasushi (pp. 150, € 17). Purtroppo non ho avuto modo neppure di leggerne una riga; vi allego, però, la presentazione dell’autore.
novità: a marzo è infatti uscito in libreria, presso i raffinati tipi dell’Adelphi, Ricordi di mia madre di Inoue Yasushi (pp. 150, € 17). Purtroppo non ho avuto modo neppure di leggerne una riga; vi allego, però, la presentazione dell’autore. La fine dell’estate è il primo romanzo, nella letteratura giapponese moderna, a narrare senza reticenze, con una sincerità quasi brutale, di un burrascoso, romantico e scandaloso triangolo amoroso.
La fine dell’estate è il primo romanzo, nella letteratura giapponese moderna, a narrare senza reticenze, con una sincerità quasi brutale, di un burrascoso, romantico e scandaloso triangolo amoroso. Mentre girovagavo qua e là per la rete, ho scoperto con piacere che una settimana fa è uscito un nuovo romanzo di Mishima, A briglia sciolta (Feltrinelli, pp. 432, € 14).
Mentre girovagavo qua e là per la rete, ho scoperto con piacere che una settimana fa è uscito un nuovo romanzo di Mishima, A briglia sciolta (Feltrinelli, pp. 432, € 14).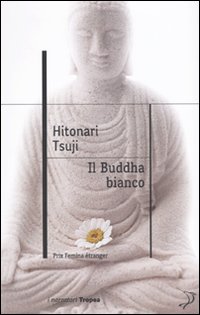
 Rieccomi qui dopo la lunga assenza natalizia. Prima di tutto, auguri (anche se un po’ in ritardo) per anno felice e ricco di piacevoli letture. 🙂
Rieccomi qui dopo la lunga assenza natalizia. Prima di tutto, auguri (anche se un po’ in ritardo) per anno felice e ricco di piacevoli letture. 🙂 Il libro di cui vi parlerò oggi, Teoria delle nuvole, è opera di un francese, Stéphane Audeguy; sempre più spesso, infatti, accade che scrittori francofoni si interessino all’universo giapponese e lo dispieghino poi nelle loro pagine (per fare soltanto due nomi: Nothomb e Detrie). Ciò, di certo, non sorprenderà se si ricorda che il japonisme, ossia il principale movimento culturale che ha portato il Sol Levante in Europa, è nato proprio all’ombra della torre Eiffel.
Il libro di cui vi parlerò oggi, Teoria delle nuvole, è opera di un francese, Stéphane Audeguy; sempre più spesso, infatti, accade che scrittori francofoni si interessino all’universo giapponese e lo dispieghino poi nelle loro pagine (per fare soltanto due nomi: Nothomb e Detrie). Ciò, di certo, non sorprenderà se si ricorda che il japonisme, ossia il principale movimento culturale che ha portato il Sol Levante in Europa, è nato proprio all’ombra della torre Eiffel. Con soltanto dieci anni di ritardo, è stato finalmente pubblicato in Italia uno dei romanzi best seller della letteratura giapponese moderna. Il titolo Battle star, con buone probabilità, non vi dirà nulla, eppure nel Sol Levante ha dato vita a manga, film e quant’altro ispirato alla storia narrata. L’autore, Takami Koushun, ha immaginato l’esistenza di una spietata Repubblica della Grande Asia dell’Est, nata dall’unione del Giappone con la Cina, in cui ogni anno, come accadeva d’altronde già ai tempi di Teseo e del Minotauro, un gruppo di giovani viene spedito in un’isola deserta per prendere parte ad un crudele gioco al massacro. Tutti contro tutti, o quasi, perché soltanto uno, alla fine, potrà sopravvivere.
Con soltanto dieci anni di ritardo, è stato finalmente pubblicato in Italia uno dei romanzi best seller della letteratura giapponese moderna. Il titolo Battle star, con buone probabilità, non vi dirà nulla, eppure nel Sol Levante ha dato vita a manga, film e quant’altro ispirato alla storia narrata. L’autore, Takami Koushun, ha immaginato l’esistenza di una spietata Repubblica della Grande Asia dell’Est, nata dall’unione del Giappone con la Cina, in cui ogni anno, come accadeva d’altronde già ai tempi di Teseo e del Minotauro, un gruppo di giovani viene spedito in un’isola deserta per prendere parte ad un crudele gioco al massacro. Tutti contro tutti, o quasi, perché soltanto uno, alla fine, potrà sopravvivere.