 Spigliate, sensuali, dirette, scaltre, autonome, dedite al lusso e ai piaceri della carne, ma anche caute, innamorate, pensierose: nella sua produzione Mori Yōko lascia spazio a una moltitudine di donne, diverse per desideri, personalità, comportamenti, condizioni di vita.
Spigliate, sensuali, dirette, scaltre, autonome, dedite al lusso e ai piaceri della carne, ma anche caute, innamorate, pensierose: nella sua produzione Mori Yōko lascia spazio a una moltitudine di donne, diverse per desideri, personalità, comportamenti, condizioni di vita.
Che siano sposate senza troppo entusiasmo, a caccia di una tresca o frequentatrici di o-miai, quelle presentate nella ricca scelta di racconti Fiabe di letto (trad. Greta Annese, Giuliana Carli e Daniela Travaglini, Lindau, 2021, pp. 288, € 22) hanno una cosa in comune: sono vive e reali quasi da staccarsi dalla pagina in ogni loro azione o pensiero, che sia truccarsi davanti lo specchio o riflettere sui propri amanti. Ben lontane dagli stereotipi che vorrebbero le donne giapponesi tendenzialmente accondiscendenti e passive, queste figure rivelano una forza d’animo sorprendente e, soprattutto, una carica emotiva ed erotica destinata a stupire più di un* lettor*.
“Una primavera che sapeva quasi di inizio estate.
La decisione improvvisa di andare lontano. Un fine settimana a Kyoto. Da sola. […] In un certo senso, non aveva mai assaporato la fortuna di essere nata donna.” (Calici da vino, p. 187)
Le storie narrate da Mori sono brevi, quasi fulminanti, e prendono spesso spunto da un incontro o da un episodio fortuito — d’altronde, non di rado basta un dettaglio per far cadere un castello di carte, illuminare il vero carattere di una persona o mettere a nudo le sue debolezze. Eppure, tormento e dolore trovano scarsa ospitalità in questi testi: piuttosto, la scrittrice e le sue eroine tendono a rivelare senso dell’humour o autoironia.
Mori non intende, però, offrire al suo pubblico mero intrattenimento, né, tantomeno, una lezione di morale: le sue narrazioni dei furin, i “legami infedeli”, mostrano invece come, nell’epoca e nei luoghi ritratti – vale a dire il Giappone degli anni Ottanta –
le donne, con molta probabilità, abbiano cominciato a guardarsi in faccia. Si scoprono dal di fuori e dal di dentro, ascoltano la propria voce, riflettono in maniera profonda su come debba esser la loro vita. (Da jōji a furin, p. 257)
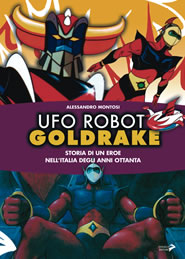
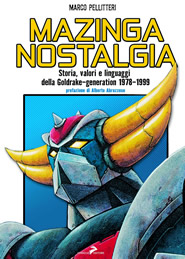 Che differenza c’è tra Capitan Harlock e il Corsaro Nero? Qual è lo scarto linguistico fra le avventure di Superman e quelle di Jeeg Robot d’Acciaio? Come inserire Candy Candy nella tradizione del feuilleton? Attraverso una minuziosa indagine incrociata, Marco Pellitteri s’interroga sui molteplici rapporti (e talvolta sui conflitti) che intercorrono tra gli eroi della tradizione e quelli delle generazioni cresciute con personaggi multimediali spesso provenienti dal Giappone.
Che differenza c’è tra Capitan Harlock e il Corsaro Nero? Qual è lo scarto linguistico fra le avventure di Superman e quelle di Jeeg Robot d’Acciaio? Come inserire Candy Candy nella tradizione del feuilleton? Attraverso una minuziosa indagine incrociata, Marco Pellitteri s’interroga sui molteplici rapporti (e talvolta sui conflitti) che intercorrono tra gli eroi della tradizione e quelli delle generazioni cresciute con personaggi multimediali spesso provenienti dal Giappone.